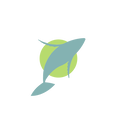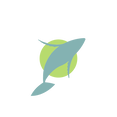Radici negate - Il senso delle foreste è un progetto di osservazione ravvicinata delle grandi aree verdi del nostro pianeta e della loro sopravvivenza in un equilibrio ormai precario. Due le tappe portate a termine fino ad ora: il Canada - Ontario e il Borneo Indonesiano - Kalimantan. Due i progetti realizzati: The Promised Land, in prima assoluta, e Neglected Roots. E uno sguardo: quello della giovane fotografa Laura Frasca che traccia un racconto per immagini e conduce nella riflessione di quello che, più o meno consapevolmente, si sta perdendo.
Una testimonianza visiva sul senso che questi grandiosi polmoni verdi custodiscono per l’intera umanità, sul loro ruolo fondamentale nel migliorare l’impatto dei cambiamenti climatici innescati dalle attività dell’uomo.
Gli scatti fotografici colgono una parte dell’esistenza delle foreste, quella legata alla scomparsa di fauna e flora primordiali, di usanze, tradizioni e consuetudini dei popoli che da sempre hanno trovato dimora in quei luoghi. Lo zoom è rivolto sia al dettaglio sia al panorama nel gioco armonico di lontano e vicino, nel delicato cammino di comprensione di un mondo che sta sfuggendo letteralmente di mano. Bianco e nero si alternano ai colori per dare espressione visiva al progetto fotografico dell’autrice, perché “ciò che stiamo negando sono le nostre stesse radici, che ci danno sostentamento ed ossigeno”.
La mostra è accompagnata da una produzione editoriale di qualità di divulgazione scientifica per bambini, ragazzi e adulti sugli aspetti del cambiamento climatico del pianeta.
Una testimonianza visiva sul senso che questi grandiosi polmoni verdi custodiscono per l’intera umanità, sul loro ruolo fondamentale nel migliorare l’impatto dei cambiamenti climatici innescati dalle attività dell’uomo.
Gli scatti fotografici colgono una parte dell’esistenza delle foreste, quella legata alla scomparsa di fauna e flora primordiali, di usanze, tradizioni e consuetudini dei popoli che da sempre hanno trovato dimora in quei luoghi. Lo zoom è rivolto sia al dettaglio sia al panorama nel gioco armonico di lontano e vicino, nel delicato cammino di comprensione di un mondo che sta sfuggendo letteralmente di mano. Bianco e nero si alternano ai colori per dare espressione visiva al progetto fotografico dell’autrice, perché “ciò che stiamo negando sono le nostre stesse radici, che ci danno sostentamento ed ossigeno”.
La mostra è accompagnata da una produzione editoriale di qualità di divulgazione scientifica per bambini, ragazzi e adulti sugli aspetti del cambiamento climatico del pianeta.
Neglected Roots
di Laura Frasca
Kalimantan, Indonesia
Il tema affrontato in questo progetto è la scomparsa, sempre più rapida, della foresta del Borneo. Questo importante evento purtroppo sta passando in sordina, chiudendo gli occhi davanti a questo scempio stiamo negando le nostre stesse “radici” che ci danno sostentamento ed ossigeno. Cosa comporta nell’immediato la scomparsa della foresta?
In primis l’estinzione di flora e fauna endemici. I grandi primati, gli oranghi (Pongo) e le nasica (Nasalis larvatus) sono i primi ad esserne colpiti, per non parlare delle conseguenze sull’intero ecosistema.
I Dayak, conosciuti in occidente come i “tagliatori di teste”, deputati da sempre al compito di proteggere la foresta, si stanno sempre più omologando alla globalizzazione ed arrendendosi alla furia cieca delle multinazionali e quindi irrimediabilmente alla perdita della foresta. Diversi gli scopi di questo progetto, uno è quello d’aiutare il Tanjung Puting National Park ad essere conosciuto e supportato. Un parco protetto che per volere di Birutè Galdikas, famosa primatologa, protegge gli oranghi dall’estinzione, attraverso la Orangutan Foundation. Inoltre con questo racconto in immagini, si vorrebbe soprattutto sensibilizzare il pubblico sul tema della deforestazione.
Laura Frasca
È difficile immaginare l’effetto provocato sulle popolazioni del nuovo mondo dai conquistadores o lo stupore degli spagnoli davanti a quegli uomini stranamente vestiti. I primi avranno pensato di avere di fronte delle divinità, divinità con il corpo per metà umano, sebbene duro e lucente, per metà animale (le popolazioni del nuovo mondo non avevano mai visto armature e cavalli). I secondi saranno stati certi di aver incontrato degli alieni. Sbarcare in Sudamerica, che allora non era Sudamerica perché l’America non era America e quindi non c’era nemmeno il Sudamerica, era come sbarcare con un’astronave su un pianeta sconosciuto. E cosa avranno provato gli spagnoli sopravvissuti alla disgraziata spedizione di Magellano e approdati, nel 1521, in Borneo? Di fronte ai Dayak e alle teste recise dei loro nemici saranno rimasti stupiti e terrorizzati.
In un libro di Jean Talon, Incontri coi selvaggi, si racconta dei primi contatti avvenuti fra i rappresentanti del cosiddetto mondo civile e quelli del cosiddetto mondo selvaggio. Attimi memorabili in cui tutto può accadere, in cui la meraviglia (o la delusione) per una scoperta travolgono i protagonisti dell’incontro. Talon racconta anche di contatti più recenti, per esempio di un incontro avvenuto negli anni ’80 fra i membri di una tribù di tagliatori di teste e un gruppo di turisti armati di macchine fotografiche. In questo incontro domina lo stupore: stupiti i turisti nel vedere tagliatori di teste in jeans e maglietta, stupiti i tagliatori di teste nel vedere uomini bianchi così interessati alle loro case, al loro cibo, alle loro maschere. Stupore a parte, i nativi abbandonerebbero seduta stante le loro case, il loro cibo, le loro maschere per far cambio con i turisti. Ovviamente i turisti non accetterebbero il cambio. Pur affascinati dal selvaggio e dal primitivo, si accontentano di mettere a fuoco immagini esotiche, in verità molto rassicuranti. Rassicurante è sapere di esser nati dalla parte giusta del mondo. Eppure il viaggio dovrebbe creare inquietudini, sconvolgere i nostri equilibri.
Oggi si viaggia per ritrovare l’equilibrio. Giorgio Manganelli sarebbe inorridito all’idea. Prima di ogni viaggio sentiva l’urgenza di fare testamento, non tanto a causa di pericoli concreti quanto per il rischio di non fare più ritorno. O meglio, per il rischio di tornare con una nuova identità. Ne “L’Infinita trama di Allah” scrive così: «Ho un amico che, tolte le tendenze maniaco depressive, i tic nervosi facciali, le ansie, gli stati confusionali, le nevrosi persecutorie e una mite paranoia, può considerarsi sostanzialmente normale». E, sempre a proposito di questo amico, dice: «Per molti anni egli non ha viaggiato, al punto che la nozione dell’Italia come immagine peninsulare era per lui del tutto favolosa. [...] Ma un giorno il destino lo fece viaggiare. Da quel momento il blando demente si trasformò in un essere irrequieto, frastornato, tremulo e affannato».
Credo che l’amico di Manganelli sia Manganelli stesso, cioè lo scrittore convinto che esistano due tipi ideali di viaggio: «il viaggio con l’autobus numero sessanta, dalla Nomentana a piazza San Silvestro, Roma, o il viaggio in jet a Singapore» (L’isola pianeta e altri settentrioni).
Come dargli torto? Una passeggiata a pochi isolati da casa può tramutarsi in un viaggio memorabile. E questo mi fa venire in mente la storia del Principe di Pandolfina, raccontata da Roberto Alajmo nel suo Repertorio dei matti della città di Palermo. L’uomo fa il voto di andare in Terra Santa nel caso in cui la moglie guarisca da una grave malattia. La guarigione avviene e l’uomo deve tener fede al sacro vincolo. Siamo agli inizi del ‘900 e un viaggio in Terra Santa è assai complicato. Allora, dopo aver calcolato la distanza fra Palermo e Gerusalemme, decide di percorrerla tutta - simbolicamente - camminando lungo i viali attorno al suo palazzo. Riesce nell’impresa accompagnato da un servitore, Felicetto, il quale - raggiunta la meta e temendo il viaggio di ritorno - persuade il Principe a rimanere, diciamo così, in Terra Santa.
Il personaggio di Alajmo non si allontana da casa eppure fa incontri memorabili (con gli altri matti della città di Palermo). Evidentemente ha imparato a separarsi dalle abitudini che ci rendono «blandi dementi».
Affinché il nostro occhio sappia cosa guardare bisogna diventare «irrequieti e frastornati». A quel punto, fotografare un tagliatore di teste del Borneo o un vicino di casa, non farà differenza: il risultato sarà in entrambi i casi stupefacente, sebbene destabilizzante. Potrebbe trattarsi di foreste in fiamme o dell’accoppiamento di oranghi, il discorso è il medesimo.
Le foto di Laura Frasca ci dicono esattamente questo: che i Dayak abitano nel nostro quartiere, che gli oranghi hanno una loro intimità domestica, che il lavoro si fa in abiti comodi, che i ragni tessono trame delicatissime mentre le foreste vanno in fiamme. Senza enfasi e senza retorica, senza sentirsi dalla parte giusta del mondo, senza voler tranquillizzare nessuno.
Mauro Orletti
Un icononauta nel Pacifico occidentale - Brevi annotazioni sullo sguardo del fotografo
Susan Sontag, nelle prime pagine del saggio Sulla fotografia, mette in luce uno degli aspetti più problematici di quell’arte, vale a dire la sua propensione al realismo, la sua presunta capacità di cogliere la realtà così come essa si presenta. E a tal proposito scrive: «Quali che siano i limiti (per dilettantismo) o le pretensioni (per ambizioni artistiche) del singolo fotografo, una fotografia – qualunque fotografia – sembra avere con la realtà visibile un rapporto più puro, e quindi più preciso, di altri oggetti mimetici. Anche i virtuosi della nobile immagine [...] vogliono, per prima cosa, mostrare qualcosa “che c’è”» [1979: 6].
A differenza di altre forme di riproduzione della realtà, come la scrittura, il disegno o la pittura che sono palesemente simulacri frutto di un lavoro di riduzione simbolica e di interpretazione, la fotografia si pone e viene spesso percepita, come rispecchiamento del mondo.
Questo probabilmente in virtù del fatto che essa non viene per lo più associata a un’idea, a un concetto, come accade con gli altri segni (o testi); essa non si separa mai dal suo referente, da ciò che rappresenta. Quando si guardano le fotografie, infatti, si dice: “questa è la foresta del Borneo”, questi sono i Dayak” e “questo è un rito funebre”.
Certo mi riferisco a una modalità di lettura riconducibile a un pubblico generico; come ricorda Roland Barthes, ne La camera chiara, non è impossibile cogliere il «significante fotografico», vale a dire il concetto a cui la foto rimanda, «solo che ciò richiede un atto secondo di sapere e di riflessione» [1980: 7].
In questa breve nota propongo alcune considerazioni per problematizzare il realismo fotografico e per dare qualche chiave di lettura del lavoro di Laura Frasca svolto nel Borneo.
Innanzitutto dovremmo cominciare a pensare che le fotografie corrispondano ad affermazioni, fatte da un fotografo, su circoscritte porzioni del mondo, partendo dal suo punto di vista. Le foto non offrono evidenze che qualcosa esiste o è successo; sono piuttosto il risultato di uno sguardo, cioè di una pratica di significazione derivante dalla selezione e organizzazione di alcuni elementi (quelli che il fotografo imprime sulla pellicola o
nella memoria digitale della fotocamera) estrapolati dalla congerie, priva di senso, di aspetti di una parte di mondo.
Lo scatto, potremmo dire, riprendendo la riflessione del sociologo tedesco Georg Simmel sul paesaggio, delimita «nella corrente caotica e nell’infinità del mondo immediatamente dato una parte, concependola e formandola come un’unità, che ora trova il proprio senso in sé stessa, tagliando i fili che la collegano al mondo» [Simmel 1913: 58].
Quella “unità”, prodotta dallo sguardo del fotografo, e questo è un secondo spunto di riflessione, è diversa da quella che potrebbe derivare dalla strutturazione del campo visivo fatta, per esempio, da un naturalista che pensa seguendo il principio di causalità o da un agricoltore indigeno che persegue fini pratici.
Lo sguardo del fotografo è culturalmente organizzato; è frutto di premesse implicite, di pre-conoscenze date per scontate, elaborate crescendo in una certa comunità, imparando una certa lingua, seguendo un certo percorso di studi, leggendo libri e riviste, viaggiando; è frutto, inoltre, di una continua interazione con il mezzo tecnico, la macchina fotografica, dell’incorporazione della sua pratica d’uso e delle possibilità di visione che esso offre. Infine, lo sguardo del fotografo, tutt’altro che ingenuo, è carico di aspettative derivanti dalla consultazione dei repertori iconografici del luogo da visitare (guide, carte geografiche, racconti di viaggi, documentari, video, resoconti etnografici, siti internet, pagine Instagram) ai quali si deve, probabilmente, il desiderio stesso di partire del fotografo.
Egli è, riprendendo l’espressione del critico cinematografico Gian Piero Brunetta che abbiamo usato nel titolo, un icononauta; ovvero un fruitore di immagini che oggi, a seguito della rivoluzione digitale, si sono moltiplicate. E quelle immagini, cioè la rappresentazione del luogo che anticipano il viaggio, non svolgono soltanto una funzione, in qualche modo, motivazionale (il cosiddetto pull factor); esse assolvono una funzione di orientamento e di guida, come fossero schemi cognitivi e interpretativi, dell’esperienza del fotografo una volta giunto sul posto [Aime, Papotti 2012: 6].
Ecco allora che le immagini proposte in questo volume, non ci parlano del Borneo, non ci dicono “questa è la foresta pluviale”, “questi sono gli oranghi”, “questi sono i Dayak”; raccontano piuttosto della costruzione e della pratica dello sguardo della fotografa Laura Frasca: potremmo dire della reazione di alcune parti di quel mondo al suo sguardo.
A questo si aggiunga un ulteriore aspetto, vale a dire che lo sguardo del fotografo risente anche dell’organizzazione sociale della visibilità del luogo di approdo, ovvero delle tattiche usate dalle comunità locali per mostrarsi e raccontarsi all’altro, all’ospite, sia esso turista, fotografo o antropologo.
Organizzazione della visibilità che è basata su una serie di componenti: i tour, predisposti per visitare le attrazioni, conoscere l’isola e i suoi abitanti; le guide locali che mostrano ciò che ritengono possa interessare ai visitatori e che offrono narrazioni del luogo volte a soddisfare le aspettative degli ospiti; i musei che raccontano le tradizioni, gli usi, i costumi e la vita di un tempo; una serie di infrastrutture: strade carrozzabili, sentieri, belvedere, punti panoramici, ponti, torrette di avvistamento, resort, camping, villaggi; e ancora i mezzi di trasporto: barche, jeep, autobus, automobili, ecc.
Le comunità ospitanti, o coloro che gestiscono sul posto l’ospitalità, solitamente configurano il territorio in modo da rendere visibili quegli elementi e quegli aspetti che i visitatori si attendono di vedere; quegli elementi che l’esperienza stessa dell’incontro, la sua narrazione e documentazione iconografica, hanno prodotto come attrazioni degne di uno sguardo.
È un vorticoso gioco di specchi quello nel quale il fotografo si trova implicato: l’organizzazione sociale della visibilità non riguarda soltanto la configurazione del territorio ma anche gli abitanti, almeno quelli che interagiscono con i turisti, i quali si mettono in scena così come sono stati dipinti, anzi, verrebbe da dire, così come sono stati fotografati.
E, per reagire (e al tempo stesso dar forma) alle esigenze dei differenti sguardi dei visitatori (turisti, fotografi, antropologi), come spiega molto bene Dean MacCannell nel suo The Tourist, si mettono in scena, appunto, all’interno di spazi organizzati che sono: le front regions (o ribalte, per riprendere la terminologia del sociologo Erving Goffman) cioè quegli spazi che gli ospiti tentano di oltrepassare alla ricerca di un esperienza non turistica (più “autentica”); le front regions turistiche, allestite per sembrare in alcune parti dei retroscena; le front regions totalmente organizzate per sembrare a tutti gli effetti dei retroscena, cioè il territorio e la
quotidianità così come sono vissuti degli indigeni; le back regions aperte agli estranei, le back regions ripulite, ecc. [1976: 107-108].
Per concludere, sempre, gli ospiti si trovano, come scriveva Mark Twain in Innocents Abroad, a cercare conferma di ciò che hanno letto e visto prima di partire e, aggiungo io, a reagire all’imponente organizzazione del setting turistico. Forse ciò che differenzia il fotografo dai turisti sta nella consapevolezza del proprio sguardo, cioè nell’acquisizione di un meta- sguardo (uno sguardo sullo sguardo): nel tener conto, tra le altre cose, anche degli aspetti che ho brevemente enunciato in questa nota.
Mi pare che Laura Frasca, nel lavoro fotografico che presenta, anziché raccontarci il Borneo, ci parli del suo sguardo e ci dia conto della sua interazione, mediata dalla macchina fotografica, con alcuni aspetti di quell’isola e con le strutture che le hanno permesso di vedere ciò che ha visto e di fotografarlo.
Christian Arnoldi
Riferimenti bibliografici
Aime M., Papotti D., L’altro e l’altrove, Einaudi, Torino,2012; Barthes R. (1980), La camera chiara, Einaudi, Torino, 1980;
MacCannell D. (1976), Il Turista, Utet, Torino, 2005;
Simmal, G (1913), Saggi sul Paesaggio, Armando, Roma, 2006; Sontag S. (1973), Sulla fotografia, Einaudi, Torino, 1978;
Urry J. (1989), Lo sguardo del turista, Seam, Formello (RM), 2000;
Aiutaci a salvare gli Orango e il loro habitat prima che sia troppo tardi cliccate sull'immagine qui sotto e date il vostro contributo
In primis l’estinzione di flora e fauna endemici. I grandi primati, gli oranghi (Pongo) e le nasica (Nasalis larvatus) sono i primi ad esserne colpiti, per non parlare delle conseguenze sull’intero ecosistema.
I Dayak, conosciuti in occidente come i “tagliatori di teste”, deputati da sempre al compito di proteggere la foresta, si stanno sempre più omologando alla globalizzazione ed arrendendosi alla furia cieca delle multinazionali e quindi irrimediabilmente alla perdita della foresta. Diversi gli scopi di questo progetto, uno è quello d’aiutare il Tanjung Puting National Park ad essere conosciuto e supportato. Un parco protetto che per volere di Birutè Galdikas, famosa primatologa, protegge gli oranghi dall’estinzione, attraverso la Orangutan Foundation. Inoltre con questo racconto in immagini, si vorrebbe soprattutto sensibilizzare il pubblico sul tema della deforestazione.
Laura Frasca
È difficile immaginare l’effetto provocato sulle popolazioni del nuovo mondo dai conquistadores o lo stupore degli spagnoli davanti a quegli uomini stranamente vestiti. I primi avranno pensato di avere di fronte delle divinità, divinità con il corpo per metà umano, sebbene duro e lucente, per metà animale (le popolazioni del nuovo mondo non avevano mai visto armature e cavalli). I secondi saranno stati certi di aver incontrato degli alieni. Sbarcare in Sudamerica, che allora non era Sudamerica perché l’America non era America e quindi non c’era nemmeno il Sudamerica, era come sbarcare con un’astronave su un pianeta sconosciuto. E cosa avranno provato gli spagnoli sopravvissuti alla disgraziata spedizione di Magellano e approdati, nel 1521, in Borneo? Di fronte ai Dayak e alle teste recise dei loro nemici saranno rimasti stupiti e terrorizzati.
In un libro di Jean Talon, Incontri coi selvaggi, si racconta dei primi contatti avvenuti fra i rappresentanti del cosiddetto mondo civile e quelli del cosiddetto mondo selvaggio. Attimi memorabili in cui tutto può accadere, in cui la meraviglia (o la delusione) per una scoperta travolgono i protagonisti dell’incontro. Talon racconta anche di contatti più recenti, per esempio di un incontro avvenuto negli anni ’80 fra i membri di una tribù di tagliatori di teste e un gruppo di turisti armati di macchine fotografiche. In questo incontro domina lo stupore: stupiti i turisti nel vedere tagliatori di teste in jeans e maglietta, stupiti i tagliatori di teste nel vedere uomini bianchi così interessati alle loro case, al loro cibo, alle loro maschere. Stupore a parte, i nativi abbandonerebbero seduta stante le loro case, il loro cibo, le loro maschere per far cambio con i turisti. Ovviamente i turisti non accetterebbero il cambio. Pur affascinati dal selvaggio e dal primitivo, si accontentano di mettere a fuoco immagini esotiche, in verità molto rassicuranti. Rassicurante è sapere di esser nati dalla parte giusta del mondo. Eppure il viaggio dovrebbe creare inquietudini, sconvolgere i nostri equilibri.
Oggi si viaggia per ritrovare l’equilibrio. Giorgio Manganelli sarebbe inorridito all’idea. Prima di ogni viaggio sentiva l’urgenza di fare testamento, non tanto a causa di pericoli concreti quanto per il rischio di non fare più ritorno. O meglio, per il rischio di tornare con una nuova identità. Ne “L’Infinita trama di Allah” scrive così: «Ho un amico che, tolte le tendenze maniaco depressive, i tic nervosi facciali, le ansie, gli stati confusionali, le nevrosi persecutorie e una mite paranoia, può considerarsi sostanzialmente normale». E, sempre a proposito di questo amico, dice: «Per molti anni egli non ha viaggiato, al punto che la nozione dell’Italia come immagine peninsulare era per lui del tutto favolosa. [...] Ma un giorno il destino lo fece viaggiare. Da quel momento il blando demente si trasformò in un essere irrequieto, frastornato, tremulo e affannato».
Credo che l’amico di Manganelli sia Manganelli stesso, cioè lo scrittore convinto che esistano due tipi ideali di viaggio: «il viaggio con l’autobus numero sessanta, dalla Nomentana a piazza San Silvestro, Roma, o il viaggio in jet a Singapore» (L’isola pianeta e altri settentrioni).
Come dargli torto? Una passeggiata a pochi isolati da casa può tramutarsi in un viaggio memorabile. E questo mi fa venire in mente la storia del Principe di Pandolfina, raccontata da Roberto Alajmo nel suo Repertorio dei matti della città di Palermo. L’uomo fa il voto di andare in Terra Santa nel caso in cui la moglie guarisca da una grave malattia. La guarigione avviene e l’uomo deve tener fede al sacro vincolo. Siamo agli inizi del ‘900 e un viaggio in Terra Santa è assai complicato. Allora, dopo aver calcolato la distanza fra Palermo e Gerusalemme, decide di percorrerla tutta - simbolicamente - camminando lungo i viali attorno al suo palazzo. Riesce nell’impresa accompagnato da un servitore, Felicetto, il quale - raggiunta la meta e temendo il viaggio di ritorno - persuade il Principe a rimanere, diciamo così, in Terra Santa.
Il personaggio di Alajmo non si allontana da casa eppure fa incontri memorabili (con gli altri matti della città di Palermo). Evidentemente ha imparato a separarsi dalle abitudini che ci rendono «blandi dementi».
Affinché il nostro occhio sappia cosa guardare bisogna diventare «irrequieti e frastornati». A quel punto, fotografare un tagliatore di teste del Borneo o un vicino di casa, non farà differenza: il risultato sarà in entrambi i casi stupefacente, sebbene destabilizzante. Potrebbe trattarsi di foreste in fiamme o dell’accoppiamento di oranghi, il discorso è il medesimo.
Le foto di Laura Frasca ci dicono esattamente questo: che i Dayak abitano nel nostro quartiere, che gli oranghi hanno una loro intimità domestica, che il lavoro si fa in abiti comodi, che i ragni tessono trame delicatissime mentre le foreste vanno in fiamme. Senza enfasi e senza retorica, senza sentirsi dalla parte giusta del mondo, senza voler tranquillizzare nessuno.
Mauro Orletti
Un icononauta nel Pacifico occidentale - Brevi annotazioni sullo sguardo del fotografo
Susan Sontag, nelle prime pagine del saggio Sulla fotografia, mette in luce uno degli aspetti più problematici di quell’arte, vale a dire la sua propensione al realismo, la sua presunta capacità di cogliere la realtà così come essa si presenta. E a tal proposito scrive: «Quali che siano i limiti (per dilettantismo) o le pretensioni (per ambizioni artistiche) del singolo fotografo, una fotografia – qualunque fotografia – sembra avere con la realtà visibile un rapporto più puro, e quindi più preciso, di altri oggetti mimetici. Anche i virtuosi della nobile immagine [...] vogliono, per prima cosa, mostrare qualcosa “che c’è”» [1979: 6].
A differenza di altre forme di riproduzione della realtà, come la scrittura, il disegno o la pittura che sono palesemente simulacri frutto di un lavoro di riduzione simbolica e di interpretazione, la fotografia si pone e viene spesso percepita, come rispecchiamento del mondo.
Questo probabilmente in virtù del fatto che essa non viene per lo più associata a un’idea, a un concetto, come accade con gli altri segni (o testi); essa non si separa mai dal suo referente, da ciò che rappresenta. Quando si guardano le fotografie, infatti, si dice: “questa è la foresta del Borneo”, questi sono i Dayak” e “questo è un rito funebre”.
Certo mi riferisco a una modalità di lettura riconducibile a un pubblico generico; come ricorda Roland Barthes, ne La camera chiara, non è impossibile cogliere il «significante fotografico», vale a dire il concetto a cui la foto rimanda, «solo che ciò richiede un atto secondo di sapere e di riflessione» [1980: 7].
In questa breve nota propongo alcune considerazioni per problematizzare il realismo fotografico e per dare qualche chiave di lettura del lavoro di Laura Frasca svolto nel Borneo.
Innanzitutto dovremmo cominciare a pensare che le fotografie corrispondano ad affermazioni, fatte da un fotografo, su circoscritte porzioni del mondo, partendo dal suo punto di vista. Le foto non offrono evidenze che qualcosa esiste o è successo; sono piuttosto il risultato di uno sguardo, cioè di una pratica di significazione derivante dalla selezione e organizzazione di alcuni elementi (quelli che il fotografo imprime sulla pellicola o
nella memoria digitale della fotocamera) estrapolati dalla congerie, priva di senso, di aspetti di una parte di mondo.
Lo scatto, potremmo dire, riprendendo la riflessione del sociologo tedesco Georg Simmel sul paesaggio, delimita «nella corrente caotica e nell’infinità del mondo immediatamente dato una parte, concependola e formandola come un’unità, che ora trova il proprio senso in sé stessa, tagliando i fili che la collegano al mondo» [Simmel 1913: 58].
Quella “unità”, prodotta dallo sguardo del fotografo, e questo è un secondo spunto di riflessione, è diversa da quella che potrebbe derivare dalla strutturazione del campo visivo fatta, per esempio, da un naturalista che pensa seguendo il principio di causalità o da un agricoltore indigeno che persegue fini pratici.
Lo sguardo del fotografo è culturalmente organizzato; è frutto di premesse implicite, di pre-conoscenze date per scontate, elaborate crescendo in una certa comunità, imparando una certa lingua, seguendo un certo percorso di studi, leggendo libri e riviste, viaggiando; è frutto, inoltre, di una continua interazione con il mezzo tecnico, la macchina fotografica, dell’incorporazione della sua pratica d’uso e delle possibilità di visione che esso offre. Infine, lo sguardo del fotografo, tutt’altro che ingenuo, è carico di aspettative derivanti dalla consultazione dei repertori iconografici del luogo da visitare (guide, carte geografiche, racconti di viaggi, documentari, video, resoconti etnografici, siti internet, pagine Instagram) ai quali si deve, probabilmente, il desiderio stesso di partire del fotografo.
Egli è, riprendendo l’espressione del critico cinematografico Gian Piero Brunetta che abbiamo usato nel titolo, un icononauta; ovvero un fruitore di immagini che oggi, a seguito della rivoluzione digitale, si sono moltiplicate. E quelle immagini, cioè la rappresentazione del luogo che anticipano il viaggio, non svolgono soltanto una funzione, in qualche modo, motivazionale (il cosiddetto pull factor); esse assolvono una funzione di orientamento e di guida, come fossero schemi cognitivi e interpretativi, dell’esperienza del fotografo una volta giunto sul posto [Aime, Papotti 2012: 6].
Ecco allora che le immagini proposte in questo volume, non ci parlano del Borneo, non ci dicono “questa è la foresta pluviale”, “questi sono gli oranghi”, “questi sono i Dayak”; raccontano piuttosto della costruzione e della pratica dello sguardo della fotografa Laura Frasca: potremmo dire della reazione di alcune parti di quel mondo al suo sguardo.
A questo si aggiunga un ulteriore aspetto, vale a dire che lo sguardo del fotografo risente anche dell’organizzazione sociale della visibilità del luogo di approdo, ovvero delle tattiche usate dalle comunità locali per mostrarsi e raccontarsi all’altro, all’ospite, sia esso turista, fotografo o antropologo.
Organizzazione della visibilità che è basata su una serie di componenti: i tour, predisposti per visitare le attrazioni, conoscere l’isola e i suoi abitanti; le guide locali che mostrano ciò che ritengono possa interessare ai visitatori e che offrono narrazioni del luogo volte a soddisfare le aspettative degli ospiti; i musei che raccontano le tradizioni, gli usi, i costumi e la vita di un tempo; una serie di infrastrutture: strade carrozzabili, sentieri, belvedere, punti panoramici, ponti, torrette di avvistamento, resort, camping, villaggi; e ancora i mezzi di trasporto: barche, jeep, autobus, automobili, ecc.
Le comunità ospitanti, o coloro che gestiscono sul posto l’ospitalità, solitamente configurano il territorio in modo da rendere visibili quegli elementi e quegli aspetti che i visitatori si attendono di vedere; quegli elementi che l’esperienza stessa dell’incontro, la sua narrazione e documentazione iconografica, hanno prodotto come attrazioni degne di uno sguardo.
È un vorticoso gioco di specchi quello nel quale il fotografo si trova implicato: l’organizzazione sociale della visibilità non riguarda soltanto la configurazione del territorio ma anche gli abitanti, almeno quelli che interagiscono con i turisti, i quali si mettono in scena così come sono stati dipinti, anzi, verrebbe da dire, così come sono stati fotografati.
E, per reagire (e al tempo stesso dar forma) alle esigenze dei differenti sguardi dei visitatori (turisti, fotografi, antropologi), come spiega molto bene Dean MacCannell nel suo The Tourist, si mettono in scena, appunto, all’interno di spazi organizzati che sono: le front regions (o ribalte, per riprendere la terminologia del sociologo Erving Goffman) cioè quegli spazi che gli ospiti tentano di oltrepassare alla ricerca di un esperienza non turistica (più “autentica”); le front regions turistiche, allestite per sembrare in alcune parti dei retroscena; le front regions totalmente organizzate per sembrare a tutti gli effetti dei retroscena, cioè il territorio e la
quotidianità così come sono vissuti degli indigeni; le back regions aperte agli estranei, le back regions ripulite, ecc. [1976: 107-108].
Per concludere, sempre, gli ospiti si trovano, come scriveva Mark Twain in Innocents Abroad, a cercare conferma di ciò che hanno letto e visto prima di partire e, aggiungo io, a reagire all’imponente organizzazione del setting turistico. Forse ciò che differenzia il fotografo dai turisti sta nella consapevolezza del proprio sguardo, cioè nell’acquisizione di un meta- sguardo (uno sguardo sullo sguardo): nel tener conto, tra le altre cose, anche degli aspetti che ho brevemente enunciato in questa nota.
Mi pare che Laura Frasca, nel lavoro fotografico che presenta, anziché raccontarci il Borneo, ci parli del suo sguardo e ci dia conto della sua interazione, mediata dalla macchina fotografica, con alcuni aspetti di quell’isola e con le strutture che le hanno permesso di vedere ciò che ha visto e di fotografarlo.
Christian Arnoldi
Riferimenti bibliografici
Aime M., Papotti D., L’altro e l’altrove, Einaudi, Torino,2012; Barthes R. (1980), La camera chiara, Einaudi, Torino, 1980;
MacCannell D. (1976), Il Turista, Utet, Torino, 2005;
Simmal, G (1913), Saggi sul Paesaggio, Armando, Roma, 2006; Sontag S. (1973), Sulla fotografia, Einaudi, Torino, 1978;
Urry J. (1989), Lo sguardo del turista, Seam, Formello (RM), 2000;
Aiutaci a salvare gli Orango e il loro habitat prima che sia troppo tardi cliccate sull'immagine qui sotto e date il vostro contributo
The Promised Land
Laura Frasca
Ontario, Canada
«E’ da molti anni che inseguo il desiderio di realizzare un grande progetto dedicato alle foreste, correndo contro il tempo e la bramosia dell’uomo. Mi piacerebbe documentare ciò che resta dei “grandi polmoni verdi”, ma soprattutto vorrei che le mie foto servissero a infondere una vera presa di coscienza e alla sensibilizzazione dell’uomo in generale. Ci sono altri miei colleghi che lo hanno fatto e lo stanno ancora facendo ma non è mai abbastanza visto che fauna e flora continuano a sparire in rapida ed inesorabile successione.
Il mezzo dell’immagine per un fotografo è l’unica risorsa che conosce e che può utilizzare per creare empatia, condivisione e collaborazione su questo tema che non può più essere delegato solo alle popolazioni che abitano ai margini o all’interno delle foreste e che ormai stanno sparendo.
Ricordiamoci che come ipotizzato nella teoria di Gaia, gli organismi viventi sulla Terra interagiscono tra loro e con le componenti inorganiche circostanti per formare un complesso sistema sinergico e autoregolante che aiuta a mantenere e perpetuare le condizioni per la vita sul pianeta; se un elemento si ammala tutto il sistema viene contaminato.
In questo progetto si “confondono” alcune foto di animali e persone “reali e non” con lo scopo di proporre una visione del passato, presente e futuro, lasciando allo spettatore il compito di interpretare il significato dell’immagine.
Inoltre sono presenti delle immagini che ritraggono ricercatori, studenti e volontari che lavorano all’interno di un vivaio, il Maajiigin Gumig Greenhouse, il cui scopo consiste nel reinserire in natura diverse specie di piante native e medicinali. Ricreare il sottobosco significa anche offrire un ambiente sano per la crescita della fauna e delle specie che fungono storicamente da sostentamento per la comunità.
Questo sforzo rappresenta però solo una piccola goccia rispetto alle problematiche ambientali e sociali da risolvere in quanto diversi studi scientifici dimostrano che le risorse idriche, il suolo e anche l’aria risultano fortemente inquinati.
Ringrazio per la disponibilità e l’estrema cortesia tutta la comunità Aamjiwnaang e tutta la mia famiglia canadese di Sarnia».
Frasca Laura
Il termine “First Nation” viene ufficialmente utilizzato dal governo a partire dagli anni '80 per sostituire il termine "Indian band" in riferimento ad un gruppo che condivide lo stesso governo e lingua. Gli Aamjiwnaang, precedentemente noti come i Chippewas di Sarnia, sono una parte della Chippewa (o Ojibwe) Nation che include circa 100.000 membri, presenti per la maggior parte nel bacino dei Grandi Laghi (Michigan, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, and Ontario). La Aamjiwnaang First Nation Reserve si trova nella parte sud della città di Sarnia nello stato di Ontario.
Nel 1858 la scoperta di ricchi giacimenti di petrolio nella vicina Oil Springs, assieme al porto naturale e ai depositi salini presenti nel substrato, ha innescato una massiccia e drammatica crescita industriale fino ad arrivare a rappresentare il 40% dell’industria chimica di tutto il Canada. Ad oggi si possono contare oltre 60 tra industrie e raffinerie presenti tra le due sponde del fiume che danno origine al complesso noto come “Chemical Valley”. Oltre ai numerosi impianti di raffinazione si affiancano centri di produzione chimica e petrolchimica che generano inquinanti di varia natura come Voc, mercurio, diossine e furani, interferenti endocrini, gas serra, determinando così una delle zone più intensamente inquinate del Canada.
Purtroppo la riserva si trova esattamente a ridosso del complesso industriale e il 60% delle emissioni inquinanti sono rilasciate all’interno dei suoi primi 5 km. Queste sostanze chimiche e gli incidenti correlati hanno un impatto enorme sulla qualità della vita e sulle attività tradizionali come la caccia, la pesca, la raccolta di medicinali e le attività cerimoniali.
Gli impatti sulla salute includono asma, difficoltà di apprendimento e problemi comportamentali, effetti sulla vita riproduttiva (alterazione della sex ratio, aborto e parto prematuro), mal di testa gravi e cronici, rash cutanei (compresi eczemi e psoriasi che colpiscono particolarmente i bambini), problemi alla tiroide e al fegato, formazione di tumori. Un recente studio evidenzia alti livelli di ospedalizzazione per paralisi cerebrale in diverse comunità dei Grandi Laghi, una delle quali è Sarnia. Ciò potrebbe essere correlato all’esposizione al metilmercurio in seguito al consumo di pesce contaminato. Inoltre a Sarnia si registra uno dei più alti livelli di casi al mondo di patologie correlate all’esposizione all’asbesto, come mesotelioma e asbestosi.
Ma l'impatto più comunemente riportato è la paura. Le persone della riserva vivono costantemente in allerta e temono la vita all'aria aperta, continuamente angosciati dalle sirene che risuonano per l’allarme di fuoriuscite di gas nocivi e di sversamenti tossici.
https://www.youtube.com/watch?v=8Tc6oXNcjxc
È difficile pensare ad un miglioramento della situazione visto che il numero di industrie e raffinerie è in continuo aumento ma le presone che vivono nella riserva non vogliono abbandonare la terra dei loro avi, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza.
Savelli Francesco
Sostieni la causa della comunità Aamjiwnaang First Nation nella lotta contro l’inquinamento ambientale provocato dalla Chemical Valley, cliccate sull'immagine qui sotto e date il vostro contributo
Ontario, Canada
«E’ da molti anni che inseguo il desiderio di realizzare un grande progetto dedicato alle foreste, correndo contro il tempo e la bramosia dell’uomo. Mi piacerebbe documentare ciò che resta dei “grandi polmoni verdi”, ma soprattutto vorrei che le mie foto servissero a infondere una vera presa di coscienza e alla sensibilizzazione dell’uomo in generale. Ci sono altri miei colleghi che lo hanno fatto e lo stanno ancora facendo ma non è mai abbastanza visto che fauna e flora continuano a sparire in rapida ed inesorabile successione.
Il mezzo dell’immagine per un fotografo è l’unica risorsa che conosce e che può utilizzare per creare empatia, condivisione e collaborazione su questo tema che non può più essere delegato solo alle popolazioni che abitano ai margini o all’interno delle foreste e che ormai stanno sparendo.
Ricordiamoci che come ipotizzato nella teoria di Gaia, gli organismi viventi sulla Terra interagiscono tra loro e con le componenti inorganiche circostanti per formare un complesso sistema sinergico e autoregolante che aiuta a mantenere e perpetuare le condizioni per la vita sul pianeta; se un elemento si ammala tutto il sistema viene contaminato.
In questo progetto si “confondono” alcune foto di animali e persone “reali e non” con lo scopo di proporre una visione del passato, presente e futuro, lasciando allo spettatore il compito di interpretare il significato dell’immagine.
Inoltre sono presenti delle immagini che ritraggono ricercatori, studenti e volontari che lavorano all’interno di un vivaio, il Maajiigin Gumig Greenhouse, il cui scopo consiste nel reinserire in natura diverse specie di piante native e medicinali. Ricreare il sottobosco significa anche offrire un ambiente sano per la crescita della fauna e delle specie che fungono storicamente da sostentamento per la comunità.
Questo sforzo rappresenta però solo una piccola goccia rispetto alle problematiche ambientali e sociali da risolvere in quanto diversi studi scientifici dimostrano che le risorse idriche, il suolo e anche l’aria risultano fortemente inquinati.
Ringrazio per la disponibilità e l’estrema cortesia tutta la comunità Aamjiwnaang e tutta la mia famiglia canadese di Sarnia».
Frasca Laura
Il termine “First Nation” viene ufficialmente utilizzato dal governo a partire dagli anni '80 per sostituire il termine "Indian band" in riferimento ad un gruppo che condivide lo stesso governo e lingua. Gli Aamjiwnaang, precedentemente noti come i Chippewas di Sarnia, sono una parte della Chippewa (o Ojibwe) Nation che include circa 100.000 membri, presenti per la maggior parte nel bacino dei Grandi Laghi (Michigan, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, and Ontario). La Aamjiwnaang First Nation Reserve si trova nella parte sud della città di Sarnia nello stato di Ontario.
Nel 1858 la scoperta di ricchi giacimenti di petrolio nella vicina Oil Springs, assieme al porto naturale e ai depositi salini presenti nel substrato, ha innescato una massiccia e drammatica crescita industriale fino ad arrivare a rappresentare il 40% dell’industria chimica di tutto il Canada. Ad oggi si possono contare oltre 60 tra industrie e raffinerie presenti tra le due sponde del fiume che danno origine al complesso noto come “Chemical Valley”. Oltre ai numerosi impianti di raffinazione si affiancano centri di produzione chimica e petrolchimica che generano inquinanti di varia natura come Voc, mercurio, diossine e furani, interferenti endocrini, gas serra, determinando così una delle zone più intensamente inquinate del Canada.
Purtroppo la riserva si trova esattamente a ridosso del complesso industriale e il 60% delle emissioni inquinanti sono rilasciate all’interno dei suoi primi 5 km. Queste sostanze chimiche e gli incidenti correlati hanno un impatto enorme sulla qualità della vita e sulle attività tradizionali come la caccia, la pesca, la raccolta di medicinali e le attività cerimoniali.
Gli impatti sulla salute includono asma, difficoltà di apprendimento e problemi comportamentali, effetti sulla vita riproduttiva (alterazione della sex ratio, aborto e parto prematuro), mal di testa gravi e cronici, rash cutanei (compresi eczemi e psoriasi che colpiscono particolarmente i bambini), problemi alla tiroide e al fegato, formazione di tumori. Un recente studio evidenzia alti livelli di ospedalizzazione per paralisi cerebrale in diverse comunità dei Grandi Laghi, una delle quali è Sarnia. Ciò potrebbe essere correlato all’esposizione al metilmercurio in seguito al consumo di pesce contaminato. Inoltre a Sarnia si registra uno dei più alti livelli di casi al mondo di patologie correlate all’esposizione all’asbesto, come mesotelioma e asbestosi.
Ma l'impatto più comunemente riportato è la paura. Le persone della riserva vivono costantemente in allerta e temono la vita all'aria aperta, continuamente angosciati dalle sirene che risuonano per l’allarme di fuoriuscite di gas nocivi e di sversamenti tossici.
https://www.youtube.com/watch?v=8Tc6oXNcjxc
È difficile pensare ad un miglioramento della situazione visto che il numero di industrie e raffinerie è in continuo aumento ma le presone che vivono nella riserva non vogliono abbandonare la terra dei loro avi, mettendo a rischio la loro stessa sopravvivenza.
Savelli Francesco
Sostieni la causa della comunità Aamjiwnaang First Nation nella lotta contro l’inquinamento ambientale provocato dalla Chemical Valley, cliccate sull'immagine qui sotto e date il vostro contributo